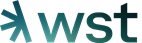Nei rapporti di lavoro con elementi di internazionalità, la normativa comunitaria individua come criterio generale, ai fini dell’individuazione della legge previdenziale applicabile, quello del luogo in cui la prestazione è svolta.
Questa regola generale è derogata in alcune specifiche situazioni tali da giustificare il ricorso ad altri criteri.
Fra queste, l’art. 13 Reg. 883/2004 individua l’ipotesi dell’esercizio abituale di attività lavorativa, sia essa subordinata o autonoma, in due o più Stati membri.
In tale ipotesi, trova applicazione la legge previdenziale dello Stato di residenza del lavoratore, se questo esercita una parte sostanziale della propria attività in tale Stato o se dipende da più datori di lavoro che hanno sede o domicilio in diversi Stati membri.
Se il lavoratore non svolge una parte sostanziale della propria attività nel proprio Stato di residenza, lo stesso è soggetto alla legge previdenziale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede o il domicilio o, se lavoratore autonomo, in cui si trova il centro degli interessi della sua attività.
1. Parte sostanziale dell’attività: criteri di individuazione tassativi o esemplificativi? - Indicazioni su cosa debba intendersi per parte sostanziale dell’attività e su quando tale requisito ricorra sono fornite dal Regolamento di applicazione n. 987/2009 e, in particolare, dal suo art. 14, comma 8 in cui si legge:
“…per parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:
a) Per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione;
b) Per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione”.
Con la sentenza KN del 4 settembre 2025, C-203/24, la Corte di Giustizia europea ha affrontato la questione se i criteri indicativi cui fa riferimento la disposizione comunitaria siano da considerarsi tassativi o se possano essere presi in considerazione anche altri criteri non tipizzati dalla normativa comunitaria.
La questione è stata sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio olandese alla luce della versione in lingua olandese del Regolamento, la cui traduzione rivela l’aggiunta del termine “anche” riferita ai criteri indicati dalla norma (“La valutazione se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro si basa anche sui seguenti criteri indicativi …”).
Secondo il giudice del rinvio olandese, l’utilizzo dell’avverbio “anche” e dell’aggettivo “indicativi”, riferito ai “criteri” da considerare, porterebbero a concludere che sia possibile tenere conto, nel quadro di una valutazione globale della situazione del lavoratore, di altre circostanze oltre quelle tipizzate dal Regolamento attuativo.
Effettivamente i rilievi del giudice olandese non sono peregrini. Al di là del “anche” che non compare in tutte le versioni linguistiche del Regolamento di applicazione, l’espressione criteri indicativi indubbiamente evoca il carattere rivelatore, sintomatico dei criteri individuati, ma non necessariamente esclusivo.
Peraltro, la stessa Commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ha fornito, nella propria Guida pratica su “La legislazione applicabile” una interpretazione che va nella direzione prospettata dal giudice olandese: “L’orario di lavoro e/o la retribuzione devono essere presi in considerazione obbligatoriamente, ma ciò non toglie che possono essere presi in considerazione anche altri criteri. Spetta alle istituzioni competenti tenere conto di tutti i criteri pertinenti e, prima di decidere in merito alla legislazione applicabile, effettuare una valutazione globale della situazione della persona” ( Lavorare in Europa: la Commissione UE pubblica l’aggiornamento della guida pratica sui diritti di sicurezza sociale ).
La Corte di giustizia ha, invece, ritenuto, sul punto, di sposare una interpretazione rigida, il cui scopo dichiarato è quello di garantire la certezza del diritto ed il principio di unicità della legge applicabile.
Dopo avere chiarito che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non è vincolante - dovendosi interpretare la stessa in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte - la Corte di giustizia ha ribadito che l’art. 14, comma 8, del Regolamento di attuazione si inserisce in un contesto normativo derogatorio rispetto alla regola generale della legge applicabile (lex loci laboris), il cui scopo è quello di evitare le possibili complicazioni che potrebbero risultare dall’applicazione della regola generale a situazioni che implicano l’esercizio di attività in due o più Stati membri.
In tale quadro, le norme derogatore mirano a garantire che i lavoratori che esercitano l’attività in due o più Stati membri siano sottoposti alla legislazione di un unico Stato membro e, a tal fine, fissano criteri di collegamento che prendono in considerazione la situazione oggettiva di tali lavoratori al fine di facilitare la libera circolazione.
Tali criteri di collegamento, nel caso di attività subordinata, sono quelli relativi all’orario di lavoro e/o alla retribuzione.
La Corte di giustizia esclude che possano essere presi in considerazione altri criteri e sottolinea come il fatto che la valutazione di tali criteri sia da effettuarsi nel “quadro di una valutazione globale della situazione del lavoratore interessato” significa non già che sia consentito aggiungere altri criteri a quelli indicati dalla norma ma che occorre prendere in considerazione l’insieme delle attività subordinate svolte dal medesimo lavoratore.
Ai sensi dell’art. 14, comma 8, Reg. 987/2009, laddove orario di lavoro e/o retribuzione nello Stato membro di residenza non raggiungano la quota del 25%, non può dirsi che una parte sostanziale dell’attività sia esercitata in tale Stato.
Ammettere il contrario significherebbe “disconoscere il carattere derogatorio dei legami di collegamento previsti” dagli artt. 12 e 14 del Reg. 883 e comporterebbe l’insorgenza di “incertezza circa l’applicazione delle norme di conflitto di leggi” enunciate al titolo II del Reg. 883, “a scapito della semplicità che tali norme sono chiamate ad instaurare per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di collegamento fondati sulla situazione oggettiva in cui si trova il lavoratore interessato”.
Quanto alle indicazioni fornite dalla “Guida pratica” redatta e approvata dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, la Corte evidenzia, da un lato, come si tratti di un documento, per sua natura, privo di forza giuridica vincolante e, dall’altro lato, che, in base alla medesima Guida, i criteri dell’orario e della retribuzione devono obbligatoriamente ricorrere. Ne deriva, secondo la Corte, che in ogni caso detti criteri non possono essere compensati da non meglio precisati criteri alternativi.
2. Il periodo di tempo rilevante - Il comma 10 dell’art. 14 Reg. 987 stabilisce che, ai fini della determinazione dello svolgimento di parte sostanziale dell’attività in uno Stato membro, occorre tenere conto della “situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili”.
Anche su tale aspetto, la sopra citata Guida pratica ha dimostrato apertura interpretativa: “anche l’attività svolta in precedenza può costituire un indicatore attendibile del comportamento futuro: per cui, qualora non fosse possibile basare una decisione sulle modalità di lavoro o sui turni di servizio previsti, sarà ragionevole prendere in considerazione la situazione dei 12 mesi precedenti e utilizzarla per valutare l’attività sostanziale. Se una società si è costituita di recente, la valutazione può basarsi su un adeguato periodo più breve”.
Detta apertura non ha, ancora una volta, trovato conforto nella sentenza della Corte di giustizia in esame, che ha, a proposito, specificato che sebbene non sia precisato “il dies a quo del periodo di dodici mesi da prendere in considerazione, risulta tuttavia chiaramente” dalla formulazione letterale della norma che si tratta dei dodici messi successivi, dato che nessuna disposizione di tale regolamento fa riferimento alla situazione passata del lavoratore interessato.
Considerato che i commi 8 e 10 dell’art. 14 Reg. 987 si riferiscono “ai casi in cui un lavoratore esercita l’attività in due o più Stati membri”, si deve ritenere che “il dies a quo debba essere quello dell’inizio dell’esercizio dell’attività in due o più Stati membri”.
Ne deriva che, al fine di valutare se un lavoratore esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, si deve tenere conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.
3. Conclusioni - I “criteri indicativi” esplicitati dall’art. 14 del Reg. 987/2009 attuativo del Reg. 883/2004 sono da interpretarsi come criteri tassativi, la cui ricorrenza è necessaria ed obbligatoria ai fini dell’accertamento in ordine alla quantificazione, inferiore o superiore al 25%, dello svolgimento di una parte sostanziale dell’attività esercitata nello Stato membro di residenza.
Altri criteri non possono essere presi in considerazione, sia in via integrativa che alternativa, rispetto a quelli previsti dalla disposizione comunitaria, al fine di garantire la certezza del diritto ed il principio di unicità della legislazione previdenziale applicabile, nel quadro della disciplina derogatoria in cui la normativa in esame si inserisce.
a cura di Silvia Lucantoni, Partner del Dipartimento di Diritto del Lavoro di WST LAW & Tax.