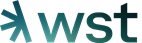La Legge 26 settembre 2025, n. 144 contenente «Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavora-tori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione»[1], introduce in Italia una forma di trattamento salariale minimo per i lavoratori, intervenendo in una questione a lungo dibattuta e controversa nel nostro Paese.
Legge delega: una lunga inerzia - L’Italia era rimasta fra i pochi Paesi europei a non prevedere nessuna normativa generale in materia, nonostante le sollecitazioni provenienti sia dalle fonti internazionali, in primis l’OIL, sia di recente dalla Direttiva Ue 2022/2041 sui salari minimi adeguati.
Per motivare questa assenza si è sostenuto che il nostro sistema di contrattazione, per la diffusione e per gli alti tassi di copertura degli accordi collettivi, offre ai lavoratori garanzie di condizioni di lavoro e retributive adeguate, in linea con le indicazioni costituzionali. Ma la validità di questo argomento è stata messo in dubbio negli anni recenti osservandosi come le nuove condizioni dei contesti nazionali e internazionale abbiano creato crescenti difficoltà alla contrattazione collettiva di offrire queste garanzie, specie nei settori e per i gruppi di lavoratori più deboli [2].
Queste difficoltà sono rese manifeste dal fatto che come attestano tutte le ricerche, i salari italiani faticano da anni a tenere il passo con l’inflazione e risultano fra i più bassi in Europa [3].
È importante, dunque, che il Parlamento sia intervenuto a rompere l’inerzia, approvando un testo legislativo che affronta in modo diretto la questione.
La via contrattuale per il salario minimo - Già il primo articolo [4] indica l’orientamento del Legislatore, stabilendo che la normativa è finalizzata a «garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti minimi economici complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati».
Si tratta di una Legge delega che quindi richiede di essere specificata nei suoi contenuti da decreti attuativi, i quali dovranno essere approvati secondo le procedure e nei termini di cui all’art. 1, commi 3 e 4.
I principi di delega lasciano come sempre spazi aperti alla decretazione, ma danno indicazioni chiare sulle questioni decisive per regolare la materia.
Una prima scelta di fondo è indicata nell’art. 1 sopra richiamato. Per garantire il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione non si definisce per legge un salario minimo adeguato, ma si punta a rafforzare la contrattazione collettiva, stabilendo criteri per dare efficacia generale ai trattamenti economici complessivi minimi da questa stabiliti.
Si è scelta dunque la via contrattuale, e non quella legislativa, per raggiungere l’obiettivo della garanzia di una retribuzione minima per i lavoratori; la norma precisa che la normativa non si applica ai dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001 che sono tutelati da normative specifiche. È una scelta in linea con la tradizione italiana e che il nostro Paese ha sostenuto, insieme ad altri Paesi, in particolare del Nord Europa, anche nel corso del dibattito per la approvazione della Direttiva europea [5].
Proprio per tenere conto delle diverse posizioni dei Paesi e delle loro Parti sociali, la versione finale dalla Direttiva ha indicato due possibili strade, una legislativa e una contrattuale, utili sia pure con varianti per raggiungere la definizione di retribuzioni minime per i lavoratori (privati).
Estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi - In questo primo esame della legge 26 settembre 2025, n. 144 mi soffermo sulle norme più importanti e che saranno oggetto di maggiori discussioni e probabilmente di controversie.
Le disposizioni cardine per il raggiungimento degli obiettivi della legge sono quelle delle lettere a) e c) dell’ art. 1, n. 2. La prima norma delega il Governo a definire per ciascuna categoria di lavoratori i contratti collettivi maggiormente applicati in riferimento al numero di imprese e dei dipendenti al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo di questi contratti costituisca ai sensi dell’art. 36 della Costituzione la condizione economica da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria.
La seconda norma delega il Governo a estendere i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi individuati come sopra ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione applicando agli stessi il contratto nazionale della categoria di lavoratori più affine.
Le due norme convergono al medesimo obiettivo di generalizzare la tutela dei minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi. La seconda in realtà può avere una applicazione pratica limitata, perché sono poche le categorie di lavoratori del tutto scoperte dalla contrattazione. Quelle bisognose di intervento sono le aree e i gruppi di lavoratori poco tutelati, che soffrono di salari bassi non in linea con le indicazioni costituzionali, perché i contratti non rispettano queste indicazioni, o anche le rispettano formalmente, ma poi di fatto non vengono applicati dagli stessi datori di lavoro che affermano di aderirvi.
Le ricerche danno conto degli alti tassi di evasione dei contratti collettivi riscontrati specie in settori economicamente deboli e/o poco organizzati sindacalmente, quali vigilanza privata, ristorazione, servizi di cura alla persona, logistica [6].
Per questo è più rilevante la prima disposizione, laddove stabilisce che il trattamento economico minimo fissato dai Contratti collettivi nazionali «costituisca, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, la condizione economica da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria». La formulazione non è tecnicamente felice.
Il punto critico da definire è la portata della espressione «trattamento economico minimo complessivo dei contratti collettivi», che è una questione complessa e oggetto di non poche controversie anche giudiziarie, data la eterogeneità della composizione delle strutture retributive e delle terminologie usate dalla nostra contrattazione [7].
Dalla individuazione degli elementi retributivi da includere nel trattamento economico minimo deriva anche quella che la norma definisce «condizione economica» da riconoscere ai lavoratori della medesima categoria ai sensi dell’ art. 36 Cost.
Estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi - Il significato della norma così definito sembra chiaro. Con essa il Legislatore ha stabilito una estensione erga omnes dei trattamenti economici minimi fissati dai Contratti nazionali di categoria. Si tratta di una scelta già seguita con modalità diverse in altri casi [8] e che la Corte costituzionale [9] ha ritenuto non incompatibile con l’art. 39 della Costituzione, in quanto riferita alla sola parte retributiva dei contratti collettivi e attuativa dell’art. 36 della stessa Carta costituzionale [10].
Quanto al significato di questa scelta va ricordato che la garanzia di retribuzione minima e adeguata così realizzata è diversa da quella attuabile attraverso una statuizione legale del salario minimo. Nella maggior parte degli Stati europei questa legislazione si è tradotta nella individuazione di una retribuzione minima con valore traversale, cioè comune a diversi settori o alla intera economia. Seguendo la via contrattuale e con la estensione erga omnes dei minimi salariali dei vari contratti collettivi, questi minimi saranno invece differenziati per le diverse categorie nella misura stabilita dagli stessi contratti.
Al rafforzamento e alla estensione della contrattazione collettiva è finalizzata anche la lett. b) dell’art. 1, n. 2. Quest’ultima pone l’obbligo alle aziende appaltatrici e sub-appaltatrici di riconoscere ai lavoratori coinvolti nella esecuzione dell’appalto trattamenti economici minimi complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi maggiormente applicati nel settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto; coerentemente prevede di rafforzare le misure di verifica e controllo in capo alle stazioni appaltanti al fine di rendere effettivi gli obblighi previsti dalla stessa norma.
Finalità simile ha la lett. h) che prevede una riforma della vigilanza sul sistema cooperativo quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta alla evasione fiscale e retributiva.
Criterio dei contratti collettivi maggiormente applicati: criticità - Se la scelta di seguire la via contrattuale è conforme alla tradizione dell’Ordinamento italiano non è così per la norma che individua i contratti collettivi cui riferirsi per stabilire le retribuzioni complessive minime e adeguate da estendere erga omnes nei Contratti collettivi nazionali di categoria maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti.
Il nostro Ordinamento fin dalle disposizioni dello Statuto dei lavoratori (art. 19) ha sempre individuato i soggetti collettivi, in particolare i sindacati, cui attribuire particolari diritti e prerogative nelle Organizzazioni maggiormente o comparativamente più rappresentative. Questo perché ha ritenuto che il riconoscimento di questi diritti dovesse essere riservato a Organizzazioni dotate di effettiva rappresentatività degli interessi delle categorie di riferimento. In realtà la qualificazione di rappresentatività non è mai stata precisata, né per i Sindacati né per le Associazioni dei datori di lavoro, da una legge che ne specificasse i contenuti.
La mancanza di definizione legislativa costituisce una anomia regolativa pressoché unica nei Paesi europei. Tale anomia è stata solo in parte compensata da interventi giurisprudenziali che hanno fornito una serie di criteri identificativi del concetto, non sempre univoci, e per altro verso da Accordi interconfederali, che peraltro essendo di natura privatistica non vincolano tutti gli attori del sistema e sono state contestate proprio dalle Organizzazioni responsabili della frammentazione contrattuale.
Questa situazione di anomia e di incertezza sui criteri della rappresentatività ha costi economici e di sistema non completamente percepiti. Il più immediato è che ha favorito la costituzione e l’attività contrattuale sia di Sindacati sia di Associazioni datoriali non rappresentativi, con la conseguenza di aggravare il disordine del nostro sistema di relazioni industriali, e di stimolare una concorrenza da parte di queste Associazioni rispetto alle Organizzazioni rappresentative, spesso offrendo condizioni retributive e normative “al ribasso”.
La mancanza di regole su questo aspetto fondamentale delle nostre relazioni industriali ha costi di sistema più generali, in quanto alimenta una concorrenza sleale fra le imprese, aumentando l’incertezza dei rapporti economici e la stessa conflittualità sociale. Per questi motivi non aver colto l’occasione di questa Legge delega per affrontare il chiarimento del concetto di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e datoriali perpetua una anomia che contribuirà a rendere più instabile il funzionamento del nostro sistema di relazioni industriali.
L’individuazione nella legge 26 settembre 2025 n. 144 del diverso criterio della numerosità delle applicazioni dei contratti collettivi [11] rappresenta un cambiamento a mio avviso non opportuno e molto discutibile. Il numero delle adesioni da parte delle imprese a un determinato contratto non è di per sé un indicatore della rappresentatività degli agenti negoziali e della corrispondenza agli interessi dei lavoratori della categoria. Anzi può prestarsi a strumentalizzazioni e distorsioni, in quanto la diffusione delle adesioni a un dato contratto può essere favorita da condizioni retributive e di lavoro particolarmente convenienti per le imprese, anche a scapito della qualità e del rispetto degli standard costituzionali.
La possibilità di simili distorsioni non è meramente teorica, in quanto l’esperienza segnala casi di contratti collettivi largamente applicati che prevedono condizioni retributive e normative sotto questi standard e che sono conclusi da Organizzazioni prive di rappresentatività, invero talora anche dalle maggiori Confederazioni. Un esempio molto noto è il Contratto collettivo c.d. “multiservizi”; inoltre, un altro contratto collettivo di larga applicazione come quello dei dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari è stato censurato dalla Corte di Cassazione in quanto prevedeva retribuzioni in contrasto con i principi dell’ art. 36 Cost. [12].
Queste sentenze rompono una lunga tradizione giurisprudenziale che ha riconosciuto retribuzioni dei contratti collettivi una sorta di presunzione di conformità alla norma costituzionale e implicano una valutazione critica del sistema di contrattazione collettiva che non può non preoccupare chi lo considera un importante istituto degli ordinamenti pluralistici democratici.
Va segnalato al riguardo che la lett. d) dell’ art. 1, n. 1 si preoccupa della presenza di simili fenomeni distorsivi del funzionamento delle relazioni industriali, prescrivendo al Legislatore delegato di contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di contratti finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori.
Interventi in caso di mancato rinnovo entro i termini dei contratti collettivi - Due ulteriori norme innovative della legge 26 settembre 2025 n. 144 sono quelle dell’art 1, n. 2, lett. f) e g). La prima prevede di introdurre strumenti di sostegno del rinnovo dei Contratti collettivi nazionali entro i termini o di quelli scaduti anche attraverso eventuali incentivi volti a bilanciare o compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi; la seconda prevede l’intervento del Ministero del Lavoro con l’adozione di misure necessarie concernenti i soli trattamenti economici minimi complessivi nel caso di contratti scaduti e non rinnovati entro i termini previsti o comunque congrui e per i settori non coperti da contrazione collettiva.
Si è già rilevato come questa ultima ipotesi sia da ritenere marginale. Invece l’intervento del Ministero previsto nella prima parte della norma ha potenzialmente una grande rilevanza, poiché le ipotesi previste per l’intervento sono alquanto frequenti nella nostra esperienza, a riprova del cattivo funzionamento del nostro sistema di relazioni industriali.
Il potere conferito al Ministero del Lavoro di prendere misure che possono comprendere l’applicazione di trattamenti economici minimi ad un settore ripresi da quelli concordati per settori contigui ha un carattere di eccezionalità, anzi è un unicum nel nostro Ordinamento.
Per questo potrebbe sollevare riserve oltre che di opportunità anche di legittimità costituzionale. Tali riserve potrebbero essere ridimensionate o superate stabilendo nei decreti delegati garanzie procedurali che accompagnassero l’esercizio del potere del Ministero, in particolare coinvolgendo la partecipazione delle Parti sociali nelle precisazioni delle condizioni e dei contenuti delle misure adatte a rispondere ai ritardi della contrattazione.
Contrattazione territoriale e differenziazione del costo del lavoro - Va rilevata l’importanza anche della lett. d) dell’ art. 1, n. 2. Essa stabilisce che la delega preveda strumenti volti a favorire lo sviluppo della contrattazione di secondo livello «con finalità adattive anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale». La novità della norma sta nel fatto che l’obiettivo di sviluppare la contrattazione decentrata, di per sé non nuovo, viene specificato indicando che tale sviluppo può anche far fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alle differenze territoriali di tale costo.
La norma è destinata a sollevare discussioni e prevedibili contrasti, non tanto per il fatto che promuove la contrattazione territoriale che in Italia è adottata solo in qualche settore, quanto perché finalizza tale contrattazione a stabilire diversità del costo del lavoro su base territoriale, da tempo rifiutate dal nostro sistema come inaccettabili gabbie salariali. Peraltro, in anni recenti non pochi osservatori hanno ritenuto troppo rigido il nostro sistema contrattuale e sostenuto la necessità di aumentare gli spazi alla contrattazione decentrata; anzitutto ma non solo ai contratti aziendali ove le dinamiche salariali sono legate a risultati di produttività e competitività variamente definiti.
La contrattazione territoriale promossa dalla norma di delega è quella che si presta di più a valorizzare i differenziali retributivi collegati alle variazioni del costo della vita, che sono spesso consistenti fra diversi territori, e che sono ritenuti utili a favorire la mobilità territoriale dei lavoratori e delle imprese.
Resta da vedere con quali strumenti questa innovazione normativa sarà attuata, in sede di decretazione; e soprattutto come sarà accolta dalle parti sindacali, in particolare se permarrà la tradizionale contrarietà delle maggiori Confederazioni o se si creeranno divisioni sulla questione, in particolare fra Cgil e Cisl.
Da ultimo va menzionato che la legge 26 settembre 2025 n. 144 introduce alcune disposizioni finalizzate a migliorare la conoscenza e il controllo delle dinamiche della contrattazione collettiva in linea con le recenti Direttive europee. In particolare, prevede che siano razionalizzate le modalità di comunicazione tra imprese ed Enti pubblici in materia di retribuzione e applicazione della contrattazione collettiva, art. 2, n. 2, lett. a); inoltre dispone all’art. 2, n. 2, lett. b) e c) di perfezionare anche con il ricorso a nuovi strumenti tecnologici le attività di ispezione e controllo nonché di attivare forme di rendicontazione dei dati raccolti dalle imprese, a fini di contrasto del lavoro sommerso.
A cura di Tiziano Treu, Of Consuel WST Law & Tax
[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230, serie generale, del 3 ottobre 2025.
[2] V., fra i molti commenti, i contributi pubblicati in Riv. giur. lav., 2023, 4; in Lav. dir. Eu., 2025, 1, dedicati al tema del salario minimo, con altre citazioni; nonché sia consentito il rinvio a T. Treu, Ancora sul salario minimo, in Le trasformazioni del lavoro: discontinuità e interdipendenze, Torino, 2024, pagg.197 ss.
[3] I dati Istat, Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali, trimestre 2025, II, segnalano che le retribuzioni contrattuali in termini reali a giugno 2025 restano ancora al di sotto di circa il 9% dei livelli di gennaio 2021, e che permangono grandi differenze per genere, generazioni, livello di istruzione e tipo di contratti.
[4] Art. 1, Legge 26 settembre 2025, n. 114 " Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. "
[5] V. T. Treu, La proposta sul salario minimo e la nuova politica della Commissione europea, in Dir. rel. ind., 2021, pagg. 1 ss.
[6] Cfr. A. Garnero, C. Lucifora, L’erosione della contrattazione collettiva in Italia e il dibattito sul salario minimo legale, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2020, 167; A. Garnero, The dog that barks does not bite: coverage and compliance of sectoral minimum wages in Italy, in IZA, Journal of labor policy, 2018, pagg. 9 ss.; O. Razzolini, Salario minimo, dumping salariale e parità di trattamento: brevi riflessioni a margine della proposta di direttiva europea, in Lav. dir. Eu., 2021, maggio.
[7] V. le analisi di V. Bavaro, “Adeguato”, “sufficiente”, “povero”, “basso”, “dignitoso”: il salario in Italia fra principi giuridici e numeri economici, in Riv. giur. lav., 2023, pagg. 510 ss.; G.A. Recchia, Il prezzo del lavoro, un’ indagine sui salari nella contrattazione collettiva nazionale, ivi, pagg. 554 ss.
[8] V. esempi, M. Magnani, Il salario minimo legale, in Riv. it. dir. lav., 2010, pagg. 790 ss.
[9] V. Corte cost. 26 marzo 2015, n. 51, in One Lavoro, Wolters Kluwer.
[10] Per commenti v., T. Treu, La questione salariale: legislazione sui minimi e contrattazione collettiva, in DRI, 2019, p. 780; G. Orlandini, Legge contrattazione collettiva e giusta retribuzione dopo le sentenze 51/2015 e 178/2015 della Corte Costituzionale, in LD, 2018, n.1, p. 9 ss. e 16 ss.
[11] V. art. 1, n. 2, lett. a) legge n. 144/2025.
[12] Cfr. le sei sentenze dell’ ottobre 2023 riportate in Riv. giur. lav. 2023, II, pagg. 497 ss. commentate da molti autori; v. anche A. Lassandari, La Suprema Corte e il contratto collettivo: alla ricerca dell’equa retribuzione, ivi, pagg. 536 ss.; M. d’Oriano, La Cassazione sul salario minimo costituzionale: squarciato il velo sul lavoro “povero”, in Lav. giur., 2023, 11, pagg. 1032 ss.; I.V. Romano, Minimo salariale nell’esperienza giuridica italiana, in Dir. prat. lav., 2023, 42, pagg. 2489 ss., § «Posizione della giurisprudenza».